|
Alla scoperta di Andrea Luigi Serassi
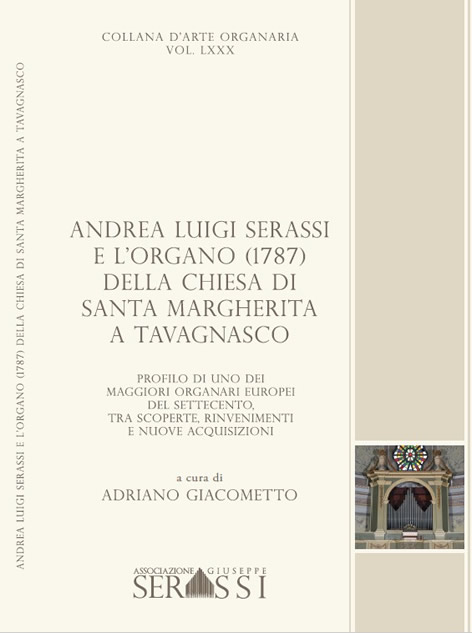
Stampato nel giugno 2023, l'ottantesimo volume della Collana d'Arte Organaria Andrea Luigi Serassi e l'organo (1787) della chiesa di Santa Margherita a Tavagnasco acquisisce maggior pregio proprio nel presente anno, in concomitanza cioè col trecentesimo anniversario della nascita dell'organaro Andrea Luigi Serassi (19 o 29/05/1725 – 30/12/1799). E ad uno dei suoi strumenti più significativi, l'organo della chiesa di Santa Margherita di Tavagnasco, in provincia di Torino, la casa discografica Antichi Organi del Canavese dedica il quarantottesimo CD del suo catalogo, in cui, ad opera del maestro Valter Savant-Levet, le sue voci vengono incise per la prima volta, risuonando in brani di autori grosso modo contemporanei al Serassi stesso.
Il volume, pubblicato col patrocinio del Comune di Tavagnasco, trova in Adriano Giacometto non solo il curatore, ma anche l'estensore della maggior parte dei testi – altri contributi provengono da Vilma Lanzetta, Paola Ponzetto, responsabile del restauro della cassa d'organo e della cantoria, e Alessandro Rigola, organaro restauratore (si citano per completezza anche le presentazioni del Curato don Luca, del Sindaco Giovanni Franchino, del Vicesindaco Paolo Torno, di Elvira Franchino – Comitato per il restauro dell'organo – e del prof. Giosuè Berbenni).
Il libro è suddiviso in due sezioni principali. La prima è dedicata all'impegnativo restauro del Serassi di Tavagnasco, ad opera dei suddetti Alessandro Rigola e Paola Ponzetto. La decisione di restaurare questo strumento, che giaceva in stato di abbandono da diversi decenni, risale al 2013, si concretizza nel 2016 e termina nel 2023: un lavoro intenso, decennale, rallentato dalla pandemia, che ha però permesso il recupero del «primo organo a due tastiere in Diocesi di Ivrea e con le sue 1514 canne distribuite su 37 comandi, [del]lo strumento dotato del maggior numero di registri dell'intero Stato Sabaudo» (pag. 57), almeno fino a quel 1787, anno in cui venne inaugurato per le festività natalizie, e «destinato a risultare il più grande strumento “di 8 piedi” collocato dalla famiglia Serassi nei suoi 175 anni di attività» (A. Giacometto, dalla scheda del CD). Dopo due capitoli introduttivi sul paese di Tavagnasco e sulla chiesa di Santa Margherita, si entra nel vivo con la storia dell'organo in oggetto, di cui si seguono la nascita, voluta e sovvenzionata non solo dall'intraprendente don Giovanni Martino Balla (1714-1794), ma anche dalla stessa popolazione tavagnaschese, la costruzione, ad opera di Andrea Luigi Serassi e del primogenito Giuseppe Antonio (o Giuseppe II, per distinguerlo dal nonno Giuseppe I), e gli interventi successivi, i pochi del 1815, attribuiti a Giovanni Battista Monti (1759-1832 c ), e il significativo ampliamento del 1885 ad opera di Costantino Mazzia (1833-1896) sotto la supervisione dell'organista Bernardo Barasa. Emerge tra le altre cose come gli interventi riflettano il cambiamento dei tempi, con la sostituzione dei registri più barocchi in favore di quelli più “operistici”. Ed emergono aspetti curiosi della sua costruzione, come il trasporto del materiale via fiume, o i rapporti con la quasi contemporanea collocazione dell'organo della Cattedrale di Santa Maria Assunta di Parma, il quale, costruito l'anno prima, avrebbe dovuto prevedere un ampliamento a stretto giro che non si verificò (o meglio, che si verificò solo nel 1789) e il cui materiale fonico confluì nella costruzione dell'organo di Tavagnasco.
Queste e altre interessanti nozioni si apprendono nella prima parte del libro, corredata, come la seconda, da un'appendice documentaria ai limiti dell'acribia, da numerose fotografie a colori e in bianco e nero, e dall'elenco degli organisti che si sono succeduti ai manuali di detto strumento, da quello che è stato probabilmente il primo, Gaudenzio de Regibus, maestro di cappella della Cattedrale di Ivrea, passando per Stefano Costantino Yon, fratello del più famoso Pietro Alessandro (cui è stato dedicato, per chi avesse seguito il nostro consiglio di lettura, un capitolo de L'uomo del metrò di Attilio Piovano, recensito per queste colonne), fino all'ultima, Rosaldina Bertino (1939-2017), organista dal 1962, cui il libro è dedicato: ultima, prima che, dalla fine degli anni Settanta, il prezioso strumento venisse «progressivamente abbandonato e dimenticato».
Parallelamente con l'avanzare del restauro dell'organo di Tavagnasco, una serie di sopralluoghi effettuati da Adriano Giacometto tra il 2017 e il 2022 su organi serassiani e non, ha portato all'acquisizione di un profilo biografico inedito di Andrea Luigi Serassi e della sua bottega, che sostanzia la seconda parte del libro. Uomo schivo e operoso, preferiva i fatti alle parole; poco più che trentenne, rimasto vedovo e padre di quattro figli, si fece prete; ma ciò non gli impedì di portare avanti l'attività di famiglia, desunta dal padre Giuseppe (1693-1760) e trasmessa al figlio Giuseppe Antonio (1750-1817), il più famoso e il più prolifico esponente della famiglia (quattordici figli), grazie al quale «Il nome Serassi, nell'immaginario comune, evoca immediatamente il modello di “Organo ottocentesco”». L'attenzione è quindi spostata sulla generazione prima, sia di organi, sia di organari. Si passano in rassegna, in ordine cronologico, i diversi strumenti collocati tra Lombardia, Piemonte ed Emilia, ripercorrendo intanto la vita di Andrea Luigi, evidenziando anche le differenze di orientamento stilistico, in termini di registri e registrazioni, tra padre e figlio (grazie a indicazioni lasciate scritte da entrambi e qui riportate), e si accenna al prosieguo dell'attività coi figli di Giuseppe Antonio. Con questo volume, l'Associazione Giuseppe Serassi dispone ad oggi di un prezioso e completo strumento sullo “stato dell'arte” attorno ad Andrea Luigi e al suo operato, e, a quanto risulta, della prima monografia a lui dedicata.
La Battaglia di Johann Kaspar Kerll (1627-1693) permette a Valter Savant-Levet di dispiegare la sua fantasia e di illustrare le possibilità foniche dell'organo. La prima traccia del CD, inciso tra il 21 e il 23 ottobre 2024 e curato da Roberto Ricco, tecnico del suono nonché Direttore Artistico, assieme ad Adriano Giacometto, della AOC, lascia il posto alle sonorità più mansuete e flautate della seconda, Introduzione e Pastorale di Bernardo Pasquini (1637-1710), cui segue la sua più austera Toccata 2º tuono, di gusto nordico, tedesco. E in ambito germanico si resta con la Ciacona di Georg Muffat (1653-1706) e la Toccata in do maggiore P. 456 del più noto Johann Pachelbel (1653-1706). Scendiamo poi in Italia con le Partite in la minore e Al Post Communio co' flauti di Domenico Zipoli (1688-1726), interessante compositore riscoperto nella seconda metà del Novecento grazie a ricerche condotte nelle Biblioteche sudamericane, terre dove svolse la sua attività di missionario. Le Partite si prestano ad esibire diversi registri e loro combinazioni, grazie alla struttura a pannelli, a suite , con variazioni sempre più incalzanti man mano che si procede verso la pirotecnica conclusione.
Con la Sonata in do maggiore (Pastorale) di Domenico Scarlatti (1685-1757) (curiosissimo l'incipit, analogo alla Sonata K 331 di Mozart!) si entra nella fascia cronologica di Andrea Luigi Serassi, come si accennava. Di qui in avanti, l'antologia di brani si concentra sul repertorio italiano: e allora, via all'Aria con variazioni di Giovanni Battista Martini (1706-1784), il “famoso” Padre Martini passato alla storia per essere stato insegnante, tra gli altri, di Mozart, Rossini e Donizetti (detto tra parentesi: il primo maestro di Donizetti, Johann Simon Mayr, fu amico ed estimatore del Serassi, come si apprende dalla seconda parte del libro; tra bergamaschi, naturali o acquisiti che siano, ci si intende…), alla Sonata in re minore di Baldassarre Galuppi (1706-1785), nei canonici quattro movimenti lento-veloce-lento-veloce della sonata da chiesa, più seriosa e meditativa, dove traspare, specialmente nei movimenti lenti, la sua “venezianità”, con un Largo cullante che ricorda Benedetto Marcello o certo Vivaldi, a due esuberanti Sonate di Andrea Luchesi (1741-1802), fra tardi influssi haendeliani e stile galante, al Concerto Primo di Pietro Morandi (1745-1813), che riporta in auge l'alternanza fra “grosso” e “concertino”, dove Savant-Levet ha modo di includere il registro dei campanini al terzo organo (peraltro, anche qui, grande inventiva e gusto per la registrazione), al Rondò: Grazioso dalla Sonata III di Gaetano Valerj (1760-1822).
Con la riduzione della Sinfonia da Gli Orazi e i Curiazi di Domenico Cimarosa (1749-1801), che conclude il disco, assistiamo al cambiamento di temperie culturale: il tramonto dell'organaria barocca e l'avvento di quella ottocentesca. L'anno è il 1796, tre anni prima della morte di Serassi. Il figlio Giuseppe Antonio aveva ormai preso in mano le redini della bottega, assistendo il padre malato (di cui viene dato conto di date e sintomi nel libro). La nutrita scelta dei brani qui in oggetto, di cui si è cercato di offrire una sintetica panoramica, permette di farsi un'idea di uno spaccato lungo due secoli del repertorio organistico forse meno conosciuto ma non per questo meno interessante. Qualitativamente valido anche l'aspetto tecnico, con un suono chiaro e pulito.
Christian Speranza
22/4/2025
|

